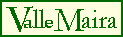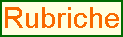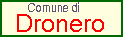|
Il Mulino della Riviera di domani: progetto di recupero
Il recupero del Mulino della Riviera intende valorizzare le caratteristiche tecnologiche e costruttive del manufatto, che si configura come vera e propria “macchina per abitare e lavorare”.
Il ripristino dell’originaria attività produttiva, legata alla trasformazione dei prodotti agricoli mediante il sistema della macinazione lenta a pietra, è perseguito mediante il recupero quasi filologico di tutte le componenti, dall’apparato tecnologico al contenitore edilizio.
Alla funzione lavorativa viene associata quella didattica/divulgativa, con la realizzazione di un percorso di visita, che permetta di osservare il ciclo produttivo all’interno degli ambienti recuperati e di cogliere esternamente la relazione tra il mulino e il territorio circostante.
Viene rinnovata inoltre la funzione abitativa, con la riqualificazione della residenza del mugnaio, al piano superiore.
A tale proposito le linee di intervento per il ripristino d’uso del fabbricato sono incentrate sull’utilizzo di materiali tradizionali (quali il legno per orditure, accessori, divisioni interne, pietra per manto di copertura e integrazioni murarie); anche il ripristino delle strutture principali e l’adeguamento degli spazi interni alle nuove funzioni abitative non opera un distacco con l’originaria impronta costruttiva, che si incentrava sulla realizzazione all’interno del grande “contenitore” di vere e proprie scatole corrispondenti ai singoli locali e alle singole esigenze.
 Tali scelte progettuali derivano da una profonda convinzione che processi di integrazione tra strutture storiche ed esigenze attuali si possano perseguire nel rispetto di caratteri formali e funzionali tipici, ai quali viene riconosciuto ad oggi un valore di contemporaneità, sia per la dimensione naturale e sostenibile che li contraddistingue, sia per il loro intrinseco e inequivocabile attributo qualitativo.
Tali scelte progettuali derivano da una profonda convinzione che processi di integrazione tra strutture storiche ed esigenze attuali si possano perseguire nel rispetto di caratteri formali e funzionali tipici, ai quali viene riconosciuto ad oggi un valore di contemporaneità, sia per la dimensione naturale e sostenibile che li contraddistingue, sia per il loro intrinseco e inequivocabile attributo qualitativo.
Dal territorio al mulino
Il recupero del Mulino della Riviera prevede il rafforzamento delle relazioni che il manufatto ha storicamente instaurato con il territorio circostante.
Collocato alla base della “riviera”, ovvero la sponda sud di Dronero, sistemata a terrazzamenti e adibita ad orti, il mulino è raggiungibile sia dall’omonima via del Molino da est, sia da un suggestivo percorso pedonale che si sviluppa tra gli orti, lungo la linea di massima pendenza.
Il tracciato risulta realizzato a trincea, incassato tra muri in pietra di delimitazione della proprietà e supera un dislivello notevole mediante una ripida e continua scalinata in pietra.
La valorizzazione di tale tracciato, tramite apposite segnalazioni, permette a chi lo desidera di raggiungere il mulino da ovest, in corrispondenza delle strutture di adduzione dell’acqua. Queste sono sormontate da una passerella che permette di scavalcare il canale Comella: da qui si potrà godere di un privilegiato punto di osservazione sul lavoro delle ruote idrauliche e di un più stretto contatto con l’acqua e il suo scorrere.
L’accesso al mulino può avvenire dall’ingresso collocato sul fronte ovest e prospiciente la piacevole piazzetta pavimentata, racchiusa tra il canale e i muri in pietra dei terrazzamenti.
L’attività produttiva
 L’indagine storica, l’analisi sull’architettura del manufatto e sul suo apparato tecnologico, confermano il ruolo centrale che il Mulino della Riviera rivestiva, fino al secolo scorso, nell’ambito degli opifici della zona. Risulta infatti essere quello più strettamente relazionato con la cittadina di Dronero, e l’unico a possedere quattro coppie di macine e che configurano un’organizzazione del lavoro di carattere proto-industriale.
L’indagine storica, l’analisi sull’architettura del manufatto e sul suo apparato tecnologico, confermano il ruolo centrale che il Mulino della Riviera rivestiva, fino al secolo scorso, nell’ambito degli opifici della zona. Risulta infatti essere quello più strettamente relazionato con la cittadina di Dronero, e l’unico a possedere quattro coppie di macine e che configurano un’organizzazione del lavoro di carattere proto-industriale.
L’intervento di riuso del manufatto ha come obiettivo principale il ripristino dell’originaria attività produttiva, incentrata sulla molitura lenta a pietra. Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso il recupero e la manutenzione straordinaria di tutti gli apparati produttivi originali e un attento recupero edilizio degli ambienti e della struttura del manufatto.
In merito al primo punto, ogni elemento del salone di lavorazione è stato recuperato e riutilizzato, previo un attento restauro conservativo delle attrezzature originali, per buona parte in legno (madie, tramogge, buratto…). I labirintici percorsi del prodotto lavorato sono stati nuovamente ripristinati, a partire dagli elevatori di granaglie e di farina del salone di lavorazione, per salire al piano superiore con gli apparati di trasporto a coclea e macchine di selezione mediante ventilazione.
Un delicato lavoro di pulizia e scultura ha riportato le macine in pietra all’originaria efficienza.
L’attività necessita inoltre di una attenta revisione tecnica e una manutenzione straordinaria di tutti i meccanismi di trasmissione del moto, collocati al di sotto delle macine, nonché degli apparati idraulici esterni. Le due grosse ruote metalliche sono state consolidate, è stato ricostruito il canale in legno che convoglia il getto d’acqua, ricollocando lo stesso sugli appositi appoggi a mensola ancorati al muro.
Sotto l’aspetto architettonico l’intervento di recupero è caratterizzato da un’attenzione particolare nei confronti delle componenti originarie, nella convinzione più generale della possibilità di rafforzare il valore architettonico e ambientale del luogo partendo dal manufatto. Allo stesso tempo, rivisitando in modo contemporaneo l’utilizzo di materiali tradizionali quali il legno e mediante inserimenti più tecnologici costituiti da superfici vetrate continue, vuole sottolineare il rinnovato rapporto tra la fabbrica storica e le esigenze attuali di riuso.
Previo consolidamento della sommità delle murature perimetrali, la copertura è stata sostituita, avendo cura di conservare le capriate portanti. Sono stati adottati legnami in larice per colmi, costane, falsi puntoni e lattes sotto losa. Il nuovo tetto è stato isolato e ventilato mediante pacchetto costituito da isolante naturale. Il nuovo manto in lose a spacco naturale e profilo irregolare è stato posato secondo il metodo locale a corsi orizzontali.
Il solaio interpiano in legno è stato conservato nella struttura ad orditura semplice delle travi e nel soprastante tavolato inchiodato (sostituendo ove necessario solamente gli elementi più degradati): esso è stato consolidato e isolato al di sopra dello stesso, in modo da preservare il soffitto originario del locale di lavorazione a piano terra.
Anche il castello in legno di appoggio delle macine è stato consolidato.
Le aperture esistenti sono mantenute tali, nelle proporzioni e nel ritmo, dotate di nuovi infissi in legno a disegno tradizionale con scuri interni, per non alterare la percezione di profondità dello sfondato rispetto al filo facciata.
La muratura viene risarcita nei punti più degradati, e sono stilati i giunti tra gli elementi, in particolare nella porzione inferiore del lato su canale, particolarmente soggetta al contatto con l’acqua. Sono qui adottati particolari intonaci risananti e protezioni impermeabili.
Un nuovo intervento di divisione interna è stao realizzato al piano primo, nel locale magazzino ove sono presenti i sistemi di trasporto delle granaglie. Si tratta dell’inserimento secondo una logica di reversibilità e leggerezza, di due scatole addossate alla parete sud, che ritagliano nell’ampio spazio del magazzino un locale ufficio e uno spogliatoio. Le scatole sono costituite da alcune pareti in legno in telaio e assito, e da altre in vetro strutturale, che permettono l’illuminazione del retrostante magazzino e il controllo diretto del percorso delle granaglie.
Questo per quanto concerne la porzione di fabbricato più strettamente legata all’attività produttiva, in sostanza la parte più rilevante e storica del manufatto.
Il volume minore, più ad est, piuttosto compromesso e degradato, è stato invece oggetto di parziale ricostruzione, nel rispetto del volume originario. Identificato alla base dal solido muro in pietra prospiciente il canale e lasciato con il paramento a vista, il volume è stato riedificato secondo una geometria semplice e “pura”, priva delle numerose superfetazioni e degli inserimenti incoerenti attualmente riscontrabili; mantenendo il riferimento alla struttura porticata, le nuove pareti a piano terra sono riproposte in legno, in sfondato rispetto la sagoma principale, munite di aperture vetrate ritagliate ove necessario.
Tale inserimento, richiamando i tamponamenti adottati nell’edilizia tradizionale in fienili e locali deposito, non altera la leggibilità della struttura e degli originari spazi.
Il volume ospita a piano terra alcuni locali a servizio dell’attività, quali ufficio/punto vendita e servizi per il pubblico e il personale, e al piano superiore parte della residenza del mugnaio.
 Elemento importante e oggetto di valorizzazione è costituito dal portico principale di ingresso, al piano terra. Le superfici aperte sono schermate da vetrate continue strutturali a telaio minimale, che non alterano la percezione di profondità degli spazi e non interrompono la relazione con l’esterno. Il nuovo ambiente si configura come spazio di filtro tra esterno e interno, e può essere utilizzato come punto espositivo dei prodotti lavorati. In questo ambiente sono inoltre collocate le macine di pietra ormai esauste, per segnalare l’attività svolta e il continuo e incessante lavoro del mugnaio.
Elemento importante e oggetto di valorizzazione è costituito dal portico principale di ingresso, al piano terra. Le superfici aperte sono schermate da vetrate continue strutturali a telaio minimale, che non alterano la percezione di profondità degli spazi e non interrompono la relazione con l’esterno. Il nuovo ambiente si configura come spazio di filtro tra esterno e interno, e può essere utilizzato come punto espositivo dei prodotti lavorati. In questo ambiente sono inoltre collocate le macine di pietra ormai esauste, per segnalare l’attività svolta e il continuo e incessante lavoro del mugnaio.
L’attuale pavimentazione in pietra del portico è estesa verso l’esterno, in corrispondenza del cortile antistante, in modo tale da rafforzare mediante l’uso di tale materiale, le relazioni tra interno e ambito circostante; in tale ambiente la pietra trova infatti ampio utilizzo nelle meticolose sistemazioni dei terrazzi della “riviera”, nei percorsi a scalinata che uniscono quote differenti, nei muretti di divisione delle proprietà.
L’abitazione

 Viene rafforzata, nel progetto di recupero, la storica consuetudine che vedeva il mugnaio essere anche “abitante” della stessa struttura produttiva. Risulta importante, sia per una economia di spazi che per soddisfare la necessità da parte dell’attività stessa di esercitare un costante monitoraggio su mezzi, attrezzature e prodotti lavorati, rafforzare la relazione tra spazi di lavoro e spazi di residenza.
Viene rafforzata, nel progetto di recupero, la storica consuetudine che vedeva il mugnaio essere anche “abitante” della stessa struttura produttiva. Risulta importante, sia per una economia di spazi che per soddisfare la necessità da parte dell’attività stessa di esercitare un costante monitoraggio su mezzi, attrezzature e prodotti lavorati, rafforzare la relazione tra spazi di lavoro e spazi di residenza.
Tale scelta risulta incentrata inoltre su una volontà di valorizzazione di un mestiere, quello del mugnaio, che più di altri si configura come una vera e propria scelta di vita, e che condiziona direttamente anche gli altri ambiti del vivere quotidiano.
Dal portico vetrato di ingresso, una scala incassata tra i volumi costruiti sale al piano primo, dove verso est si sviluppa l’abitazione del mugnaio. Gli ambienti sono ricavati nel rispetto dell’attuale volumetria e la distribuzione è resa più flessibile, secondo le attuali esigenze.
Particolare attenzione è data alle finiture, mediante adozione di materiali tradizionali. Le aperture sono contornate dalla tradizionale cornice in calce bianca, in rilievo, riproposta come segno identificativo della porzione “civile”; gli infissi sono in legno con eventuali scuri interni, per far risaltare la percezione di sfondato dell’apertura. Un nuovo balcone con assito e mensole in legno è collocato sul fronte sud, secondo un disegno di facciata coincidente con il sottostante portico tamponato. Un secondo balcone è collocato ad est, in corrispondenza del portico vetrato, e protegge il sottostante ingresso. Le ringhiere sono in legno e hanno disegno tradizionale (assito pieno oppure stecche verticali tra due correnti) e sono fissate ai passafuori del tetto mediante montanti.
Il percorso didattico
 Allontanandosi dalla stringente logica della museificazione classica, per altro di difficile adozione nel caso specifico a causa delle limitazioni che imporrebbe in particolar modo alla rinnovata esigenza produttiva, che risulta caratterizzata da un indissolubile rapporto tra edificio e lavoro quotidiano, e cogliendo allo stesso tempo il profondo valore di testimonianza storico-tecnologica, il Mulino della Riviera non rinuncia alla propria potenzialità didattica e divulgativa.
Allontanandosi dalla stringente logica della museificazione classica, per altro di difficile adozione nel caso specifico a causa delle limitazioni che imporrebbe in particolar modo alla rinnovata esigenza produttiva, che risulta caratterizzata da un indissolubile rapporto tra edificio e lavoro quotidiano, e cogliendo allo stesso tempo il profondo valore di testimonianza storico-tecnologica, il Mulino della Riviera non rinuncia alla propria potenzialità didattica e divulgativa.
Configurandosi come interessante insieme di apparati e strutture a supporto di un procedimento lavorativo (troppo celermente) abbandonato, il mulino si configura come chiaro esempio della stretta relazione, instaurata sino al Novecento, tra economia agricola locale e procedimento di trasformazione dei prodotti.
L’interessante collocazione del manufatto, relazionato in modo semplice ed efficace con il corso d’acqua e con la sponda sistemata ad orti, lo rende ideale punto di partenza per un percorso conoscitivo di valore didattico, formativo e turistico allo stesso tempo.
 Giungendo dalla via del Molino e sostando nel cortile lastricato, si avrà la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio: il visitatore potrà introdursi nel manufatto secondo una logica graduale, che rende labile il confine tra esterno e interno, oltrepassando il portico vetrato e calandosi nel locale lavorazione. Qui verrà illustrato il percorso delle granaglie, fino alla trasformazione finale in prodotto lavorato, in primo luogo mediante l’effettiva lavorazione svolta dalle macchine e soprattutto dalla gestualità del mugnaio all’opera, il quale ogni giorno affronta con rinnovato entusiasmo un mestiere così antico.
Giungendo dalla via del Molino e sostando nel cortile lastricato, si avrà la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio: il visitatore potrà introdursi nel manufatto secondo una logica graduale, che rende labile il confine tra esterno e interno, oltrepassando il portico vetrato e calandosi nel locale lavorazione. Qui verrà illustrato il percorso delle granaglie, fino alla trasformazione finale in prodotto lavorato, in primo luogo mediante l’effettiva lavorazione svolta dalle macchine e soprattutto dalla gestualità del mugnaio all’opera, il quale ogni giorno affronta con rinnovato entusiasmo un mestiere così antico.
 Ogni oggetto e macchinario sarà illustrato mediante apposite schede, e ogni ambiente sarà dotato di pannelli di immediata lettura che faciliteranno la comprensione degli usi e dei procedimenti.
Ogni oggetto e macchinario sarà illustrato mediante apposite schede, e ogni ambiente sarà dotato di pannelli di immediata lettura che faciliteranno la comprensione degli usi e dei procedimenti.
La relazione con il quotidiano procedimento di lavorazione sarà quindi sottolineata dalla sostanziale operatività del mulino, tutt’altro che teatrale, con gli aromi sprigionati dalla farina, il fruscio delle granaglie che scorrono nei condotti, il moto ripetitivo degli ingranaggi, la vibrazione del robusto castello in legno scosso dal soprastante lavoro delle pesanti macine in pietra.
Al piano superiore negli ambienti rinnovati secondo un fedele recupero, si potranno osservare gli ambiti di stoccaggio dei prodotti, che verranno commercializzati al piano terra.
Ideale proseguimento del percorso di visita è il tracciato che permette di raggiungere il mulino da ovest. La ripida discesa a trincea tra gli orti della Riviera sfocia proprio in prossimità della presa d’acqua sul canale Comella. Da questo suggestivo e fresco angolo, protetto dall’edificio e dai muri in pietra dei terrazzamenti, una passerella permette di sormontare il canale stesso, e di avere un privilegiato punto di osservazione sul lavoro delle ruote idrauliche, nonché un diretto contatto con l’acqua, da sempre elemento di forza e dipendenza dell’edificio.
Dal mulino al territorio: attività correlate
 Il Mulino della Riviera si configura inoltre come importante punto di riferimento di una più ampia rete di percorsi tematici che, sviluppandosi in tutta l’area della Valle Maira sui tracciati esistenti dei Percorsi Occitani o GTA, permettono di scoprire un vasto paesaggio fatto di canali, mulini, macchine idrauliche dai più svariati utilizzi. I tracciati, che spesso si trovano a scavalcare torrenti mediante suggestivi ponti in pietra, sono spesso relazionati all’acqua e agli edifici che ad essa devono il loro funzionamento. Spesso si incontrano borghi costruiti appositamente lungo i torrenti e costituiti prevalentemente da edifici idraulici o mulini, a testimonianza di un universo che fino a pochi decenni fa risultava popolato e ricco di economie locali frutto di ataviche e spesso immutate abitudini. Esempi efficaci sono la borgata Combe di Celle Macra, o le borgate di Elva, Mulini Abelli, Mulini Allioni.
Il Mulino della Riviera si configura inoltre come importante punto di riferimento di una più ampia rete di percorsi tematici che, sviluppandosi in tutta l’area della Valle Maira sui tracciati esistenti dei Percorsi Occitani o GTA, permettono di scoprire un vasto paesaggio fatto di canali, mulini, macchine idrauliche dai più svariati utilizzi. I tracciati, che spesso si trovano a scavalcare torrenti mediante suggestivi ponti in pietra, sono spesso relazionati all’acqua e agli edifici che ad essa devono il loro funzionamento. Spesso si incontrano borghi costruiti appositamente lungo i torrenti e costituiti prevalentemente da edifici idraulici o mulini, a testimonianza di un universo che fino a pochi decenni fa risultava popolato e ricco di economie locali frutto di ataviche e spesso immutate abitudini. Esempi efficaci sono la borgata Combe di Celle Macra, o le borgate di Elva, Mulini Abelli, Mulini Allioni.
Altre volte ci si imbatte, passeggiando lungo i percorsi che un tempo collegavano i centri abitati, in strutture isolate, collocate lungo un canale ormai secco. Edifici abbandonati, diruti, dai quali emergono ancora macine in pietra o elementi che ci permettono di ricostruire il loro funzionale passato. Moltissime le testimonianze della molitura di granaglie, della pesta della canapa, o della lavorazione dei metalli, che hanno interessato anche i territori più alti della Valle Maira.
Questo racconto fatto di un’autonomia di risorse, di un’indipendenza dai grandi sistemi, si oppone nettamente alla visione di marginalità che nel Novecento è stata associata ai territori montani. Traspare, al contrario, la ricchezza di scambi e produzioni di una terra che oggi più che mai risulta collocata in posizione strategica, non più con funzione di confine, ma come cerniera tra nazioni.
A tale proposito il Mulino della Riviera vuole, con la sua testimonianza, dare le possibilità a chi è interessato di intraprendere un approfondimento che si dilata ben oltre le proprie mura, in un’ottica più estesa di comprensione e valorizzazione della “cultura materiale” dei luoghi.
Il progetto vuole infatti sottolineare che la rivalutazione di economie tradizionali, oggi scomparse quasi del tutto, proprio per le caratteristiche qualitative legate alla naturalità e sostenibilità che le contraddistinguono, è alla base dell’impostazione di nuovi sistemi di sviluppo locale. Il tutto in una più ampia visione legata alla gestione del territorio che nelle aree montane si configura come vera e propria manutenzione del paesaggio.
Tavole


|





 Tali scelte progettuali derivano da una profonda convinzione che processi di integrazione tra strutture storiche ed esigenze attuali si possano perseguire nel rispetto di caratteri formali e funzionali tipici, ai quali viene riconosciuto ad oggi un valore di contemporaneità, sia per la dimensione naturale e sostenibile che li contraddistingue, sia per il loro intrinseco e inequivocabile attributo qualitativo.
Tali scelte progettuali derivano da una profonda convinzione che processi di integrazione tra strutture storiche ed esigenze attuali si possano perseguire nel rispetto di caratteri formali e funzionali tipici, ai quali viene riconosciuto ad oggi un valore di contemporaneità, sia per la dimensione naturale e sostenibile che li contraddistingue, sia per il loro intrinseco e inequivocabile attributo qualitativo. L’indagine storica, l’analisi sull’architettura del manufatto e sul suo apparato tecnologico, confermano il ruolo centrale che il Mulino della Riviera rivestiva, fino al secolo scorso, nell’ambito degli opifici della zona. Risulta infatti essere quello più strettamente relazionato con la cittadina di Dronero, e l’unico a possedere quattro coppie di macine e che configurano un’organizzazione del lavoro di carattere proto-industriale.
L’indagine storica, l’analisi sull’architettura del manufatto e sul suo apparato tecnologico, confermano il ruolo centrale che il Mulino della Riviera rivestiva, fino al secolo scorso, nell’ambito degli opifici della zona. Risulta infatti essere quello più strettamente relazionato con la cittadina di Dronero, e l’unico a possedere quattro coppie di macine e che configurano un’organizzazione del lavoro di carattere proto-industriale. Elemento importante e oggetto di valorizzazione è costituito dal portico principale di ingresso, al piano terra. Le superfici aperte sono schermate da vetrate continue strutturali a telaio minimale, che non alterano la percezione di profondità degli spazi e non interrompono la relazione con l’esterno. Il nuovo ambiente si configura come spazio di filtro tra esterno e interno, e può essere utilizzato come punto espositivo dei prodotti lavorati. In questo ambiente sono inoltre collocate le macine di pietra ormai esauste, per segnalare l’attività svolta e il continuo e incessante lavoro del mugnaio.
Elemento importante e oggetto di valorizzazione è costituito dal portico principale di ingresso, al piano terra. Le superfici aperte sono schermate da vetrate continue strutturali a telaio minimale, che non alterano la percezione di profondità degli spazi e non interrompono la relazione con l’esterno. Il nuovo ambiente si configura come spazio di filtro tra esterno e interno, e può essere utilizzato come punto espositivo dei prodotti lavorati. In questo ambiente sono inoltre collocate le macine di pietra ormai esauste, per segnalare l’attività svolta e il continuo e incessante lavoro del mugnaio.
 Viene rafforzata, nel progetto di recupero, la storica consuetudine che vedeva il mugnaio essere anche “abitante” della stessa struttura produttiva. Risulta importante, sia per una economia di spazi che per soddisfare la necessità da parte dell’attività stessa di esercitare un costante monitoraggio su mezzi, attrezzature e prodotti lavorati, rafforzare la relazione tra spazi di lavoro e spazi di residenza.
Viene rafforzata, nel progetto di recupero, la storica consuetudine che vedeva il mugnaio essere anche “abitante” della stessa struttura produttiva. Risulta importante, sia per una economia di spazi che per soddisfare la necessità da parte dell’attività stessa di esercitare un costante monitoraggio su mezzi, attrezzature e prodotti lavorati, rafforzare la relazione tra spazi di lavoro e spazi di residenza. Allontanandosi dalla stringente logica della museificazione classica, per altro di difficile adozione nel caso specifico a causa delle limitazioni che imporrebbe in particolar modo alla rinnovata esigenza produttiva, che risulta caratterizzata da un indissolubile rapporto tra edificio e lavoro quotidiano, e cogliendo allo stesso tempo il profondo valore di testimonianza storico-tecnologica, il Mulino della Riviera non rinuncia alla propria potenzialità didattica e divulgativa.
Allontanandosi dalla stringente logica della museificazione classica, per altro di difficile adozione nel caso specifico a causa delle limitazioni che imporrebbe in particolar modo alla rinnovata esigenza produttiva, che risulta caratterizzata da un indissolubile rapporto tra edificio e lavoro quotidiano, e cogliendo allo stesso tempo il profondo valore di testimonianza storico-tecnologica, il Mulino della Riviera non rinuncia alla propria potenzialità didattica e divulgativa. Giungendo dalla via del Molino e sostando nel cortile lastricato, si avrà la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio: il visitatore potrà introdursi nel manufatto secondo una logica graduale, che rende labile il confine tra esterno e interno, oltrepassando il portico vetrato e calandosi nel locale lavorazione. Qui verrà illustrato il percorso delle granaglie, fino alla trasformazione finale in prodotto lavorato, in primo luogo mediante l’effettiva lavorazione svolta dalle macchine e soprattutto dalla gestualità del mugnaio all’opera, il quale ogni giorno affronta con rinnovato entusiasmo un mestiere così antico.
Giungendo dalla via del Molino e sostando nel cortile lastricato, si avrà la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio: il visitatore potrà introdursi nel manufatto secondo una logica graduale, che rende labile il confine tra esterno e interno, oltrepassando il portico vetrato e calandosi nel locale lavorazione. Qui verrà illustrato il percorso delle granaglie, fino alla trasformazione finale in prodotto lavorato, in primo luogo mediante l’effettiva lavorazione svolta dalle macchine e soprattutto dalla gestualità del mugnaio all’opera, il quale ogni giorno affronta con rinnovato entusiasmo un mestiere così antico. Ogni oggetto e macchinario sarà illustrato mediante apposite schede, e ogni ambiente sarà dotato di pannelli di immediata lettura che faciliteranno la comprensione degli usi e dei procedimenti.
Ogni oggetto e macchinario sarà illustrato mediante apposite schede, e ogni ambiente sarà dotato di pannelli di immediata lettura che faciliteranno la comprensione degli usi e dei procedimenti. Il Mulino della Riviera si configura inoltre come importante punto di riferimento di una più ampia rete di percorsi tematici che, sviluppandosi in tutta l’area della Valle Maira sui tracciati esistenti dei Percorsi Occitani o GTA, permettono di scoprire un vasto paesaggio fatto di canali, mulini, macchine idrauliche dai più svariati utilizzi. I tracciati, che spesso si trovano a scavalcare torrenti mediante suggestivi ponti in pietra, sono spesso relazionati all’acqua e agli edifici che ad essa devono il loro funzionamento. Spesso si incontrano borghi costruiti appositamente lungo i torrenti e costituiti prevalentemente da edifici idraulici o mulini, a testimonianza di un universo che fino a pochi decenni fa risultava popolato e ricco di economie locali frutto di ataviche e spesso immutate abitudini. Esempi efficaci sono la borgata Combe di Celle Macra, o le borgate di Elva, Mulini Abelli, Mulini Allioni.
Il Mulino della Riviera si configura inoltre come importante punto di riferimento di una più ampia rete di percorsi tematici che, sviluppandosi in tutta l’area della Valle Maira sui tracciati esistenti dei Percorsi Occitani o GTA, permettono di scoprire un vasto paesaggio fatto di canali, mulini, macchine idrauliche dai più svariati utilizzi. I tracciati, che spesso si trovano a scavalcare torrenti mediante suggestivi ponti in pietra, sono spesso relazionati all’acqua e agli edifici che ad essa devono il loro funzionamento. Spesso si incontrano borghi costruiti appositamente lungo i torrenti e costituiti prevalentemente da edifici idraulici o mulini, a testimonianza di un universo che fino a pochi decenni fa risultava popolato e ricco di economie locali frutto di ataviche e spesso immutate abitudini. Esempi efficaci sono la borgata Combe di Celle Macra, o le borgate di Elva, Mulini Abelli, Mulini Allioni.